Nuovi orizzonti per l’editoria nel mondo digitale
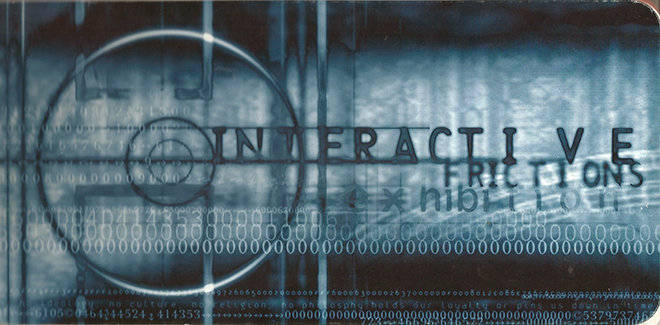
L’intervento dell’ex ministro della Cultura Massimo Bray in occasione dell’inaugurazione del corso di dottorato in “Humanities & Technologies” dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, a Napoli, il 20 gennaio 2016 (da www.massimobray.it).
Il rapporto tra informatica e discipline umanistiche, spesso considerato secondario fino a non molto tempo fa, sta rapidamente acquistando un ruolo di primo piano nella formazione universitaria e post-universitaria. La causa è a mio avviso da rintracciarsi in una radicale ridefinizione della dicotomia tra materie letterarie e materie scientifiche, ridefinizione che sta avvenendo, e che dunque non è facile ancora analizzare e comprendere appieno. È chiaro, tuttavia, che discipline scientifiche e humanities saranno sempre meno contrapposte e anzi andranno sempre più intrecciandosi in un futuro che ci prospetta lo sviluppo sempre maggiore di una società della conoscenza. A chiunque operi nel settore della cultura è ormai nota la necessità di familiarizzarsi con linguaggi, contenitori e mezzi di comunicazione sempre più avanzati, che presuppongono conoscenze sempre più tecniche e specifiche.
I numerosissimi blogger freelance che si occupano di informazione culturale, i social media manager delle più varie istituzioni culturali, gli editori digitali, i numerosi altri profili professionali emergenti dalla rivoluzione digitale in atto, tutti sono venuti in contatto, solo per fare alcuni esempi, con la marcatura SEO, con gli hashtags, i metadati, tutto ciò che consente di comunicare cultura attraverso il web 2.0. E, d’altronde, la comunicazione della cultura sta assumendo un ruolo sempre più importante all’interno del mondo digitale.
L’avvento della rivoluzione digitale ha avuto e sta avendo infatti un impatto enorme sulla nostra vita quotidiana, sui nostri modi di informarci, di comunicare, di affrontare i problemi. Le tecnologie digitali sono state definite da Douglas Engelbart, inventore del mouse, «molto più significative dell’invenzione della scrittura o addirittura della stampa»; anche non condividendo la portata eccessiva di tale affermazione, non si può ormai negare che esse stiano contribuendo, al pari di altre grandi invenzioni passate e presenti, a mutare il corso della storia, plasmando nuovi modelli di comportamento e nuove strutture sociali, cambiando la realtà in cui viviamo e il modo in cui ci rapportiamo ad essa.
Nell’intraprendere una riflessione sul rapporto tra cultura – e nella fattispecie su editoria –, e mondo digitale vorrei prendere le mosse da un libro che da sempre amo citare perché è una guida preziosa per la comprensione del tempo che stiamo vivendo: mi riferisco alle Lezioni americane di Italo Calvino, dove appaiono quasi profetiche, in particolare, le parole che l’autore dedica all’idea di «rapidità», non appena pensiamo all’impatto che l’immediatezza consentita dalle tecnologie digitali ha in tutte le nostre attività quotidiane e soprattutto – per quello che ora maggiormente importa – su alcuni dei nostri modi di rapportarci alla cultura.

Basti pensare, ad esempio, a come si sono trasformati le modalità di accesso ai libri e l’atto stesso del leggere: le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, dovunque e in qualsiasi momento, un numero sterminato di libri, un numero che possiamo considerare di fatto infinito se rapportato alla durata limitata della nostra esistenza. Ed è un patrimonio accessibile in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione: in viaggio, durante gli spostamenti urbani, sul luogo di lavoro, nei tanti momenti di pausa e di attesa. Quanto e come questa disponibilità immediata di un numero enorme di testi, coniugata all’attitudine di usufruirne in una modalità che definirei quasi “mordi e fuggi”, influisca sulla nostra capacità di fissare e organizzare le nostre conoscenze, è una questione particolarmente cogente.
Parallela ad essa, c’è la lezione della «visibilità»: altra parola-chiave delle Lezioni americane che mi sembra cogliere un aspetto cruciale della contemporaneità. Calvino si chiede: «quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella che si usa chiamare la “civiltà dell’immagine”? Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate?»; e, poco più avanti, denuncia «il pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini». Sono parole scritte, evidentemente, molti anni prima della diffusione mondiale di Internet e della conseguente moltiplicazione esponenziale di quel flusso ininterrotto e onnipervasivo delle immagini, che Calvino definiva già allora come un vero e proprio «diluvio».
Si era da tempo affermata, all’epoca in cui egli scriveva, quella «civiltà delle immagini» che già dalla metà del secolo scorso aveva visto l’umanità dei Paesi occidentali investita da un flusso continuo di immagini di ogni genere e che tanti intellettuali, filosofi, sociologi – dal Vance Packard dei Persuasori occulti alla Scuola di Francoforte, fino alla «cattiva maestra televisione» di Karl Popper – avevano denunciato nei suoi aspetti deteriori. Oggi, tuttavia, questo processo è giunto a uno stadio successivo, dal momento che la Rete ci mette a disposizione in modo immediato e gratuito una quantità incalcolabile di immagini, con la possibilità di visualizzare istantaneamente qualsiasi oggetto, monumento, luogo, personaggio – vero o immaginario – che abbiamo il desiderio di vedere.
Occorre essere consapevoli che la differenza non è semplicemente quantitativa, perché oggi non siamo più soltanto spettatori passivi di questa enorme quantità di immagini: una condizione che esponeva ed espone già di per sé al rischio, da un lato, di un isterilirsi della capacità di immaginazione individuale, e dall’altro – nelle letture più ‘apocalittiche’ – a quello di un controllo o comunque di un condizionamento ‘dall’alto’ delle idee e dei comportamenti da parte di più o meno concreti poteri di vario genere, sulla scia delle distopie huxleyana e orwelliana.
Oggi non si tratta più soltanto di questo, perché la possibilità di accedere di nostra iniziativa pressoché a qualsiasi immagine abbiamo la necessità o il desiderio di vedere, espone a rischi di tipo diverso, a cominciare da quello rappresentato da una conoscenza fai-da-te che si illude, questa volta ‘dal basso’, di poter fare a meno di qualsiasi confronto con le opinioni informate e competenti, così come di qualsiasi riscontro con quelli che sono, molto banalmente, i dati di fatto; e che di conseguenza rischia di dare origine a un caos incontrollato nel quale non è più possibile distinguere il vero dal falso, ciò che è attendibile da ciò che è frutto di fantasia o di malafede, ciò che è documentato da ciò che è soltanto immaginato o persino inventato.
In che modo occorre rispondere – ci si potrà e dovrà chiedere – a questi e a siffatti rischi oggettivamente impliciti nella vertiginosa diffusione dei media digitali, ai quali d’altra parte sarebbe anacronistico e irragionevole rinunciare alla luce dei molti e indiscutibili vantaggi che essi apportano alle nostre vite? La giusta risposta non può che venire dal ruolo della cultura, intesa come conoscenza rigorosamente scientifica e come riflessione critica. Un ruolo che mette al centro delle nostre riflessioni il libro, e seguendo Hans Blumenberg, il mondo che conosciamo come metaforico del libro. Un mondo che per secoli abbiamo conosciuto e abbiamo saputo leggere – come dei decifratori, lettori attenti – proprio come fosse un libro.
E cruciale diviene allora il ruolo delle università, dei centri di ricerca, degli istituti culturali e delle case editrici: perché la diffusione del sapere non può fare a meno di quella indispensabile funzione di filtro e certificazione delle nozioni e della loro interpretazione che è affidata da un lato e innanzitutto alla comunità scientifica, ma dall’altro – in misura non meno rilevante – all’editoria, che alla prima si affida per la realizzazione e il controllo dei contenuti, ma in assenza della quale il patrimonio di conoscenze e di saperi che essa produce non avrebbe modo di essere comunicato a un pubblico più ampio di quello dei soli addetti ai lavori.
L’Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha celebrato nel 2015 i suoi novant’anni di attività, ha sempre seguito con attenzione l’evoluzione delle tecniche editoriali, dei supporti e dei media digitali nel corso della sua attività: percorso già avviato con la produzione di cd e dvd allegati ai tradizionali prodotti cartacei, e proseguito con lo sviluppo del portale Treccani.it, che sempre più sta diventando uno dei fulcri dell’attività editoriale dell’Istituto.
Un’attività che, essa stessa, è stata interessata da mutamenti rapidi e forieri di conseguenze inimmaginabili fino a pochi anni fa. Nel corso della mia ormai più che ventennale esperienza all’interno della Treccani, infatti, ho avuto modo di seguire da vicino la vera e propria ‘rivoluzione’ che ha investito il mondo dell’editoria, e che ha spesso stravolto persino il nostro modo tradizionale di ‘fare’ i libri, ovvero le tecniche, le metodologie di ricerca, i canali di promozione, mentre l’avvento di un nuovo sistema di reperire informazioni – la Rete, naturalmente – ha progressivamente trasformato l’intera missione dell’Istituto.
Per comprendere la portata reale di queste trasformazioni occorre, però, partire dall’inizio. Fondato nel 1925, l’Istituto si proponeva di costruire, tramite la realizzazione dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, un’opera editoriale che doveva contribuire in modo determinante alla crescita culturale italiana («la maggior prova intellettuale dell’Italia nuova», come scrisse Treccani): un lavoro che, attraverso il contributo dei maggiori studiosi italiani e internazionali – da Giovanni Gentile a Enrico Fermi, da Filippo Tommaso Marinetti a David Ben Gurion, da Rita Levi-Montalcini a Claude Lévi-Strauss, solo per citarne alcuni – è proseguito ininterrotto per quasi un secolo, tanto che proprio lo scorso anno si è pubblicata la nona Appendice dell’Enciclopedia.
A ripercorrere questa storia e a narrarla al pubblico, la Treccani ha dedicato nel 2015 molte energie, con una nutrita serie di eventi e iniziative culturali, editoriali e multimediali, quali la mostra Treccani 1925-2015. La cultura degli Italiani, il volume Treccani. Novanta anni di cultura italiana 1925-2015 e le 90 parole pubblicate sul portale Treccani.it, scelte per rappresentare ognuno degli anni di vita della Treccani, da cruciverba del 1925 a tinder del 2014, iniziativa che ha riscosso un notevole successo sul web e sui social network.
Se l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione e alla divulgazione della conoscenza in Italia è rimasto immutato nel corso di una storia che si avvia ormai a divenire secolare, sono mutate invece, necessariamente, le strategie. La sfida del digitale, e in particolare il confronto con i modelli wiki, ci ha infatti condotto a compiere una scelta che per certi versi reputo coraggiosa: quella di mettere a disposizione su Internet il ricchissimo patrimonio informativo costituito dalla banca dati dell’Istituto.
È ormai impensabile, oggi, che qualcuno – dovendo ricercare rapidamente le informazioni essenziali su un dato argomento – non si rivolga agli strumenti offerti dalla Rete: sono convinto che il ruolo di un’istituzione come la Treccani sia proprio quello di proporre un’offerta di contenuti dotati della stessa esaustività e facilità di consultazione che caratterizzano le più note enciclopedie online a contenuto aperto, ma che ad esse affianchi la garanzia della certificazione scientifica data dall’autorialità delle voci e dal complesso sistema di controllo e verifica dei dati che, fin dalle origini, costituisce il metodo di lavoro caratteristico dell’Istituto, fornendo così un’alternativa autorevole ai contenuti generati dagli stessi utenti, spesso soggetti a errori, imprecisioni, ai cosiddetti ‘vandalismi’ – cioè all’inserimento di errori o falsi nelle voci enciclopediche –, e comunque non organizzati in un coerente sistema di conoscenze.
Stabilendo, poi, una distinzione tra il patrimonio delle informazioni enciclopediche e quello dell’approfondimento critico, si è scelto di riservare a quest’ultimo i tradizionali prodotti editoriali cartacei, che sono sempre più strumenti di riflessione e di studio, nei quali può trovare posto quella rigorosa manifestazione del pensiero, lungamente elaborata e ponderata, che non ha modo di esprimersi nei modi e nelle forme consentite dalla Rete. Tutto ciò, ovviamente, con la primaria preoccupazione di non disperdere i saperi accumulati nel corso della storia dell’Istituto: in primo luogo i saperi materiali, l’artigianalità e la cura che contraddistinguono le opere Treccani, come nel caso dei volumi d’arte e dei facsimili di antichi codici, ma anche il patrimonio delle pratiche editoriali e dell’attentissima cura redazionale delle opere. Opere che rilanciano con forza la dimensione materiale e artigianale del libro, della sua bellezza di artefatto di pregio, del piacere di sfogliare le pagine, di godere della qualità della stampa, delle immagini, delle legature, insomma di tutti quegli aspetti che, tuttora, distinguono il libro dal suo ‘rivale’ digitale, ovvero l’e-book.
Sottolineo che ho usato la parola ‘rivale’ con intento in un certo senso provocatorio, perché sono invece convinto che il proseguire su una contrapposizione sterile tra supporti tradizionali e supporti di nuova generazione sia quanto meno inutile, se non dannoso; è infatti, in primo luogo, evidente come l’idea di una scrittura dinamica, ‘aumentata’, abbia già manifestato numerosi antecedenti ben prima della rivoluzione digitale: esempi tra i più noti ne sono Tristram Shandy e Il nome della rosa, come opportunamente sottolineato da Emma Giammattei, che è risalita ancora più indietro nella storia paragonando al rapporto tra libro cartaceo e libro digitale il paradigma umanistico che permise di riscoprire e rimettere in circolazione dei testi antichi attraverso una tecnica nuova, quella appunto della stampa a caratteri mobili; un processo che portò ad un aumento esponenziale dell’accessibilità della conoscenza, almeno per la realtà del XV e XVI secolo. «La rivoluzione postumanistica – scrive Emma Giammattei – oggi continua quel processo su scala planetaria, rispetto all’Europa dei dotti, ma secondo il medesimo duplice orientamento: della ricerca come avventura e della organizzazione-controllo dei dati ottenuti», secondo il modello enciclopedico di «un sapere aperto e sempre in formazione».
«Il coesistere tra la sequenza del voltare pagina e lo scorrere dei caratteri sullo schermo, per scivolamento, è in tal senso produttivo, e destinato forse a durare ancora qualche secolo», conclude Giammattei, e non posso che condividere in pieno l’assunto, poiché mi pare ormai già evidente che le due tipologie, cartacea e digitale, possono assumere – e in parte hanno già iniziato ad assumere – un ruolo complementare nella missione di diffondere e incrementare, specie tra i più giovani, l’attitudine alla lettura, allo studio, alla ricerca.
Una missione che l’Istituto continua a portare avanti mantenendosi fedele al suo scopo originario di fornire a tutti un accesso immediato e allo stesso tempo certificato al sapere, e tuttavia adattandosi al mutare dei tempi e delle tecnologie, ovvero istituendo un nesso reale e non solo teorico fra tradizione e innovazione.
In un’epoca caratterizzata da un flusso continuo e indiscriminato di notizie, immagini, informazioni e interpretazioni, il principale compito del sapere enciclopedico è proprio, a mio avviso, quello di fornire al vastissimo pubblico degli utenti di Internet alcuni indispensabili strumenti di orientamento che consentano loro di usufruire con consapevolezza e senso critico di queste nuove realtà e di saper distinguere, nella miriade di informazioni presenti in Rete, ciò che merita di essere conosciuto e preservato; impedendo, allo stesso tempo, che l’incessante succedersi di notizie e di stimoli sempre nuovi e sempre diversi dal quale siamo quotidianamente investiti finisca, prima o poi, per farci perdere il contatto con la dimensione del passato e della storia, che è fondamento non soltanto della nostra cultura, ma anche della nostra identità di individui e di comunità.
Le nuove tecnologie, con il loro veicolare un sapere in molti casi caotico e frammentario, non possono e non devono sostituire l’incontro con il libro – cartaceo o digitale che sia, ma un libro, inteso come strumento di accesso privilegiato alla conoscenza di noi stessi e del mondo, anzi dei molti mondi che la facoltà immaginativa degli scrittori di ogni epoca ci ha fatto conoscere; quell’esperienza celebrata da Calvino nel saggio del 1984 Il libro, i libri, laddove definiva la lettura «un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre».
L’avvento del digitale sta cambiando ed è destinato a cambiare sempre di più il modo di leggere e quello di pubblicare; ed è un passaggio, si badi, di cui è difficile oggi prefigurare, in prospettiva, le proporzioni: certamente i libri cartacei continueranno ad essere stampati e a circolare, ma è possibile per alcuni che essi finiscano per rappresentare, in futuro, un fenomeno di nicchia; oppure è possibile – e forse a mio avviso più probabile – che le due tipologie di libro siano destinate invece a convivere, un po’ come la radio e la televisione, o come il cinema e la televisione. Il punto decisivo in questo delicato passaggio è costituito, a mio avviso, dal ruolo dell’editore, a cominciare da quella funzione di filtro, di mediazione e di scelta nella quale si sostanziano innanzitutto il compito e la responsabilità di una casa editrice, a maggior ragione in un’epoca nella quale la possibilità per chiunque di pubblicare qualsiasi cosa su internet e la presenza in rete di una quantità enorme di informazioni spesso non controllate e quasi mai criticamente vagliate rende davvero cruciale questa assunzione di responsabilità.
L’obiettivo deve essere, anche nel passaggio alla pubblicazione su Internet o in forma di e-book, quello di affermarsi con l’autorevolezza e la qualità dei contenuti veicolati. Ed è un obiettivo fondamentale da due differenti punti di vista: da quello della stessa sopravvivenza della professione editoriale, che solo in questo modo può realisticamente restare, per così dire, ‘sul mercato’ e – in definitiva – continuare ad avere senso; e, cosa più importante, da quello della cultura in generale, che in assenza di un serio filtro scientifico ed editoriale corre rischi gravissimi, come ha dimostrato anche una recente inchiesta nella quale un articolo di medicina volutamente privo di fondamento e pieno degli errori più elementari è stato accettato da oltre la metà delle circa 300 riviste scientifiche on-line alle quali era stato proposto.
È qui che si pone dunque il problema della qualità della conoscenza, che può davvero considerarsi tale solo quando le nozioni e i fenomeni sono ricomposti e analizzati nella loro complessità sistemica e il sapere può contare su una certificazione sicura perché autorevole: un compito, questo, che nell’era della ‘democratizzazione dell’informazione’ le istituzioni culturali sono ad ogni livello chiamate ad assolvere. Non si tratta di una sfida alla modernità – il sapere ‘istituzionalizzato’ della comunità degli studiosi contro il sapere ‘diffuso’ promosso dalla Rete –, ma di una sfida della modernità, che impone un ripensamento strategico delle modalità di somministrazione e divulgazione di un sapere critico e certificato, che sfrutti le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Già nel 1997 la saggista britannica Frances Cairncross, nel suo libro The death of distance, evidenziava come, durante l’era dei più rapidi cambiamenti tecnologici che il mondo avesse mai vissuto, al centro della rivoluzione della comunicazione risiedesse un valore dal quale l’umanità avrebbe tratto beneficio: la diffusione globale della conoscenza.
Purtroppo siamo ben lungi dal raggiungere un simile obiettivo: tuttavia la progressiva diffusione degli strumenti digitali, insieme al superamento del digital divide – che anche nel nostro Paese limita notevolmente, in base alle diverse aree geografiche, ceti, livelli di cultura, la capacità degli utenti di accedere ai contenuti del web culturale –, può certamente fornire un valido aiuto nel garantire un sapere più condiviso, una consapevolezza e un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini nella vita pubblica e una responsabilizzazione collettiva verso i beni comuni, perché la società dell’informazione sia sempre più una società della conoscenza e della partecipazione.
Massimo Bray
